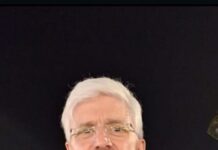Editoriale del n. 2/2024 de La Magistratura
di Stefano Celli
Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini
Durante gli studi universitari mi sono imbattuto, come tutti i compagni, nella questione “funzioni della pena”, prima mentre studiavo diritto costituzionale poi, più in profondità, durante lo studio del diritto penale.
Sono seguiti l’esame di diritto penitenziario e alla fine anche durante la tesi, che si occupava della discrezionalità del giudice nell’applicazione delle sanzioni sostitutive.
Nella passionalità che caratterizza non solo l’azione, ma anche la riflessione dei giovani, giuristi e non giuristi giungevo alla conclusione che la sostituzione della pena detentiva breve fosse sostanzialmente obbligata. Fatti salvi i divieti oggettivi e soggettivi, all’epoca molto più corposi e poi lentamente erosi dalle modifiche legislative successive, tanto che quelli “il giudice deve sostituire la pena detentiva breve”.
Il mestiere, poi, mi ha indotto a ricredermi: forse mi ero spinto un po’ troppo avanti. L’esperienza mi ha indicato casi, non rari, per i quali, nonostante la pena fosse contenuta, era consigliabile, se non necessario, mantenere la pena detentiva.
Come spesso accade ho potuto presto constatare che anche questa generalizzazione, come tutte le generalizzazioni, potrà forse servire per le riflessioni sistemiche, non per le decisioni concrete. Insomma mai come in questo caso il “dipende” è un’espressione calzante. È indice di cerchiobottismo o di equilibrio? lo lascio decidere a chi legge.
Restano, tuttavia, alcuni punti fermi.
Sicuramente la “tensione” della pena verso la rieducazione. Una lettura piana dell’articolo 27, terzo comma ultima parte, non lascia spazio a dubbi: la pena deve tendere alla rieducazione del condannato.
Si tratta pur sempre di una pena, quindi non si può sostenere che il condannato già rieducato non dovrebbe patire pena; oppure che non avrebbe senso punire Tizio perché rispetto al momento del fatto egli è ormai “un’altra persona”. Argomenti sicuramente pregevoli, ma non direttamente legittimati dal terzo comma.
Probabilmente la confusione è fra “tensione” e “funzione”. Se si sostiene che la pena ha “solo” funzione di rieducazione, è ovvio che in molti casi l’applicazione di una pena sarebbe priva di senso.
La lettura dell’articolo 27 non deve però essere parcellizzata. La congiunzione fra le due frasi che compongono il comma è “forte”: non rimanda a due statuizioni autonome, ma regola la medesima pena; e la prima parte richiama implicitamente la pena detentiva o comunque privativa della libertà.
La rieducazione è quindi una delle caratteristiche della sanzione, non la caratteristica esclusiva. Tuttavia, nello stesso tempo, è quella menzionata esplicitamente, per cui si può affermare tranquillamente che è la più importante, perché in forza dell’articolo 27 non può mai mancare.
La Corte costituzionale, peraltro, ha evidenziato le plurime direzioni del precetto, utilizzandolo ad esempio in materia di ignoranza della legge penale (sentenza 364/1988).
Se la pena non è collegata a un precetto conosciuto o agevolmente conoscibile, come potrà contribuire alla rieducazione del reo? Egli riterrà sempre ingiusta la condanna, pur avendo commesso il fatto, visto che non aveva idea (e non per sua colpa, ovviamente) che fosse reato.
È quindi lecito affermare che per il delitto colposo il tema della funzione della pena e della tensione rieducativa costituisca un nodo centrale.
Affermazione che vale sia per la fase della cognizione, sia per quella dell’esecuzione o, meglio, del trattamento vero e proprio.
Proprio su questo intendo svolgere alcune considerazioni ulteriori.
La funzione della pena nella fase di trattamento del delitto colposo
Una necessaria premessa di fatto: fino a qualche anno fa, la possibilità di porre in esecuzione carceraria una pena detentiva per reati colposi era un’ipotesi quasi di scuola.
Ciò (non) accadeva in primo luogo per motivi sistematici, collegati a:
- la misura delle pene (anche per delitti) normalmente contenute, sia nei minimi che nei massimi edittali;
- la tendenza (che non riguarda solo i reati colposi, ma è di carattere generale) a prediligere pene vicine al minimo edittale, o inferiori in forza dell’applicazioni di attenuanti e diminuzioni premiali per il rito scelto;
- la circostanza che la pena veniva, di norma, sospesa; il recidivo (in senso atecnico, visto che dal 2005 la recidiva è prevista solo per i delitti dolosi, anzi non colposi) è figura che compare raramente e spesso beneficia di una seconda sospensione, limiti legali permettendo;
- nei casi più gravi, esaurita la sospensione (magari in forza di condanne per altri delitti) o superato il limite, l’applicabilità di misure alternative, specialmente l’affidamento.
A partire dalla metà dello scorso decennio, tuttavia, le pene per alcuni reati colposi, in particolare per quanto riguarda quelli occasionati dalla circolazione stradale, sono state aumentate in misura assai rilevante.
Non intendo qui indagare legittimità politica, efficacia deterrente, costituzionalità di queste scelte.
Mi preme solo ricordare che questa scelta, come quasi tutte le scelte, è figlia di molti genitori, alcuni noti, altri no; alcuni orgogliosi di esserlo, mentre altri non lo sono, non per pudore ma perché si tratta di genitori inconsapevoli; altri non sono genitori, perché sono fatti, anche se causati pur sempre dagli uomini.
Tra i genitori (delle varie specie) indico:
- la diffusione del fenomeno;
- il verificarsi di alcuni casi eclatanti, che peraltro meritano sempre le prime pagine dei giornali o un posto in sommario dei telegiornali, a differenza di altri omicidi colposi che questo spazio stentano a ricavare;
- il fatto che spesso si tratti di omicidi plurimi (in auto si è spesso due, tre, quattro);
- la circostanza che i decessi riguardino spesso i giovani;
- l’accoppiata incidente-ebbrezza o incidente-alterazione da assunzione di stupefacenti.
Questi fatti colpiscono molto il sentire comune, e l’opinione pubblica ha estrema difficoltà ad accettarle.
E ancora (fra i genitori), va ricordata la mai sopita tendenza, che negli ultimi due anni ha ricevuto ulteriore spinta, al panpenalismo e all’individuazione del carcere come unica risposta da dare a qualunque fenomeno antisociale: inventiamo un nuovo reato, alziamo le pene ed è tutto risolto. Risolto forse con l’opinione pubblica, ma sappiamo bene che il problema resta.
E c’è infine, spiace dirlo, un apporto non so quanto consapevole della magistratura, le cui pronunce, per lungo tempo, specialmente nei gradi superiori, si sono caratterizzate per una particolare mitezza. Ricordo la confidenza di un (ormai anziano) presidente di tribunale, già consigliere e poi presidente di sezione di corte a me giovane pretore: caro Stefano, alcuni colleghi hanno delle difficoltà, delle ritrosie, diciamo così, a considerare veri reati quelli colposi. Quel tempo sembra ormai finito e in effetti la tendenza alla clemenza, che più che esercizio di equità sembrava ricerca di un senso della propria ragion d’essere, è ormai, in questi termini, una vera e propria eccezione.
Tuttavia il reato colposo è la cifra della società moderna, quanto meno di quella occidentale.
Possiamo escludere con alto grado di probabilità dal nostro orizzonte la commissione di un delitto doloso (rapina, omicidio, corruzione, furto, maltrattamenti), non altrettanto possiamo dire per i delitti colposi: siamo tutti potenziali delinquenti colposi.
E del resto credo che prevedere alcune condotte colpose come illecite anche penalmente, corrisponda a un livello di società culturalmente avanzata: non perché penalizza, ma perché ha la forza di esigere dai cittadini una particolare attenzione in alcuni campi che coinvolgono la tutela di beni e valori rilevantissimi, come l’ambiente, la vita, l’incolumità fisica.
Nello stesso tempo, tuttavia, proprio per la sua natura “involontaria”, il delitto colposo è quello più difficile da allontanare dagli orizzonti delle possibili condotte personali.
Per escludere l’omicidio volontario dall’orizzonte delle opzioni di norma è sufficiente essere cresciuti in un contesto minimamente coeso; per evitare le condotte colpose, invece, bisogna ricorrere a una profonda, continua educazione, una vera e propria educazione permanente: educazione alla sicurezza, al rispetto delle norme, alla formazione.
Ci si pone cioè su un piano antecedente non solo logico ma anche storico, o almeno cronologico, rispetto al momento della trasgressione. E quanto più sarà lontana, e precedente, la formazione e l’educazione al rispetto dei valori fondamentali e delle regole di prevenzione, tanto più questa sarà efficace.
Per la gran parte dei consociati, almeno quelli che non hanno informato le proprie scelte di vita a valori illeciti, la pulsione omicidiaria, ammesso che si manifesti, nasce e si reprime quasi sempre in contesto temporale quasi unitario (e lo stesso vale per i furti, le rapine, le truffe).
Per i reati colposi non è così: da un lato la condotta colposa normalmente si inserisce in atti quotidiani e ripetuti, dall’altro l’evento ha una genesi remota e multifattoriale, solo in parte rientrante nel dominio dell’agente e solo in parte immediatamente da lui percepibile come correlata all’evento da evitare.
La consapevolezza dei rischi che alcune condotte recano, è frutto di attenzione, educazione, formazione, maturità anche psicologica.
Ho avuto modo di confrontarmi con alcuni psicologi, per altre questioni e il discorso è andato sulla capacità di un giovane di valutare le implicazioni della propria condotta, dominare i suoi istinti, valutare in maniera compiuta il contesto in cui egli si sta muovendo.
Ebbene ho imparato che gli studi clinici hanno potuto stabilire che, per un giovane di 16/17 anni, è assolutamente normale, mentre cammina per strada, cambiare repentinamente direzione, scartando a destra o a sinistra, perché ha visto qualcosa che lo ha attratto (un amico dall’altra parte della strada, un negozio con un oggetto che gli interessa). Il corollario, introdotto dal mio interlocutore, che però mi è rimasto scolpito nella memoria, era “capisci perché è meglio non dare la patente a un sedicenne?”.
È opportuno tenere presenti questi elementi che, pur se formano la cornice del nucleo centrale del trattamento sanzionatorio, nel momento della determinazione e in quello esecutivo, sono coerenti con le conclusioni che cercherò di trarre e argomentare.
Dicevo prima che fino a poco tempo fa gli accertamenti relativi a illeciti colposi non sfociavano, tendenzialmente, in esecuzione di pene detentive. Pene edittali alternative, minimi (e massimi) edittali delle pene detentive non elevati, misure alternative, concorrevano ad allontanare dall’orizzonte del condannato l’ipotesi del carcere.
Ora, in concreto, non è più così. Non è un evento frequente, anzi è raro, ma i minimi (non solo i massimi) edittali molto elevati, rende concreta la possibilità che anche chi ha commesso un delitto “solo” colposo possa dover scontare una pena detentiva.
E allora anche in questo caso occorre interrogarsi sulla funzione rieducativa della pena. E tra le variabili da considerare trova posto il tipo di reato e l’elemento soggettivo, nonché il rapporto con la persona offesa.
E allora, se teniamo conto degli elementi comuni a tutti gli illeciti (e alle pene conseguenti) e a quelli specifici di reati come quelli di cui ci stiamo occupando, penso che emerga con una certa evidenza l’opportunità, se non la necessità, di un trattamento, se mi passate l’espressione, “particolarmente” differenziato.
L’esecuzione della pena irrogata per un delitto colposo
Ogni reato produce una ferita, una lesione del bene. Più o meno grave, a seconda del bene e delle condizioni della persona offesa. Il delitto colposo ha una sua particolarità, e cioè quella di incidere, spesso, sulla salute, l’integrità fisio-psichica, quando non sulla vita. È vero che ci sono offese relative ad altri beni (si pensi ai disastri ambientali) ma anche questi, in fondo, si riflettono comunque sui diritti personalissimi e inalienabili.
Ebbene in questi delitti, specie quelli che derivano da infortuni sul lavoro, circolazione stradale, colpa professionale, è naturale che la risposta sanzionatoria tenga conto della dimensione risarcitoria.
Non alludo al solo risarcimento ordinario, sia esso del danno morale, materiale, biologico. La vittima, che di norma chiede un risarcimento di questo tipo, spesso è in cerca di ben altra soddisfazione, una soddisfazione diversa dal ristoro materiale.
Di cosa si tratta? Non è semplice da spiegare ma, per cercare di farmi capire meglio mi spiego con un esempio. Ho svolto funzioni di pretore per sette anni, fino alla soppressione dell’ufficio e più di una volta mi è capitato di dare voce, e ascoltare, le persone (non tecnicamente ma sostanzialmente) offese di omicidi stradali. Queste, a fronte di un processo rapidamente concluso con sentenza di applicazione della pena, protestavano.
Perché, mi chiedevo io? Abbiamo fatto presto, la sentenza passerà in giudicato e lo “sconto” è insignificante. Ebbene, mentre alcuni probabilmente erano arrivati con un desiderio che se non era di vendetta poco ci mancava, altri, semplicemente, volevano “che il reo si rendesse conto” di quel che aveva causato. E invece, dicevano, “non è nemmeno venuto”.
E di quel che aveva fatto doveva rendersene conto in un processo, in cui loro, persone offese, parenti, amici delle persone offese, potevano far comprendere a tutti cos’era successo.
E si capiva bene che questo percorso poteva essere, per loro sicuramente sanante, di guarigione di quelle ferite che, pur lasciando un segno, si rimarginano in determinate condizioni.
E per il reo? Ci arrivo dopo.
Questi ragionamenti che facevo orami più di 25 anni fa, mi sono tornati alla mente dopo tanto tempo, quando la dottrina e lo stesso legislatore, prima comunitario, poi, un po’ più timidamente, nazionale, si sono confrontati con la figura della vittima.
Figura abbastanza negletta, per la verità, nei fatti oltre che nelle norme.
Non è questa la sede per affrontare il tema, colossale, della giustizia riparativa ma mi fermo a una riflessione.
Il carcere, quando è nato, è stata una conquista di civiltà. Con il passare del tempo se ne sono individuati i molti limiti, anche prima di arrivare alla situazione intollerabile del sovraffollamento che, come sa chiunque si occupi anche di sfuggita del tema, non è certo questione che è nata ora, né due o tre anni fa.
E gli studiosi più attenti sanno da tempo che la risposta sanzionatoria incentrata sul carcere crea molti più problemi di quelli che risolve, motivo di più per modulare il trattamento e individuarne uno quanto più possibile individualizzato e specifico.
In questa specificità siamo autorizzati, ora, a includere la variabile vittima, ovviamente su base volontaria (volontarietà che riguarda entrambi, reo e vittima).
Non mi fermo ad analizzare i singoli passaggi sostanziali e processuali, ma penso che immaginare un percorso “sanzionatorio” che tenga conto, appunto, della vittima, costituisca un passo importante nel percorso evolutivo della pena.
Con rigore, senza fughe in avanti, ma anche con un’elasticità, non voglio dire fantasia, volta ad adeguare la pronuncia che comprende l’individuazione della pena, la sua quantificazione, le modalità di esecuzione comprese eventualmente quelle relative alla definizione anticipata al caso concreto.
E siccome tutte le modifiche, specie quelle destinate a incidere su veri e propri simboli, vorrei dire totem, moderni, e cioè il carcere come unico e solo luogo di esecuzione della pena (sfido chiunque a negare che nell’immaginario collettivo questa è un’idea accettata comunemente), devono essere lente, gradate, progressive, mi pare che uno dei primi gradini della scala che conduce all’ampliamento degli strumenti esecutivi, possa essere proprio l’illecito colposo.
Percorso gradato che parte dai reati, dalle situazioni, forse sarebbe meglio dire dalle ferite, meno inaccettabili, perché dovute a un contributo soggettivamente meno “impegnativo”: alla colpa e non al dolo.
Situazioni, ferite, modi di curarle che la vittima può accettare meglio. Può cominciare a pensare, la vittima, a un ristoro che si allontani dalla “tipo di pena” che spesso viene invocata, anche nei detti popolari (ti metto, anzi “ti sbatto” in galera “a marcire” e butto la chiave: un’iperbole, ma a sentire certe interviste fino a un certo punto). O che comunque contempli un percorso individualizzato, una ripresa dei rapporti, della relazione sociale che il reato ha danneggiato, leso interrotto.
Mi metto, tento di mettermi, nei panni di chi legge.
E mi dico: ma questo qua cosa è venuto a raccontarci? La filosofia? Noi volevamo un po’ di cassazione, qualche bel caso da analizzare.
Insomma, qualcosa che consentisse, a chi finisce di leggere, di dire “ho qualcosa su cui riflettere”.
Sono in difetto, lo ammetto. Però invoco un’attenuante e indico una via di fuga.
L’ordinamento ha strumenti sanzionatori e definitori sempre più ampi. Lo spazio si sta allargando, sia per i nuovi strumenti, sia per la lenta, ma inesorabile, limatura dei vincoli.
Però è evidente che dobbiamo maneggiare con la massima consapevolezza questi strumenti. Non è facile, perché occorre mantenere l’equilibrio fra la ricezione acritica (si definisce qualunque processo, quale che sia il reato, con un programma di messa alla prova “pur che sia”) e chiusura pregiudiziale.
L’equilibrio ci consente di proseguire su questa strada, faticosa, ma affascinante, propria del “rendere giustizia”. E spero di aver dato un piccolo contributo per allargare lo sguardo su un’altra faccia, a volte nascosta, a volte dimenticata, del terribile diritto di punire.